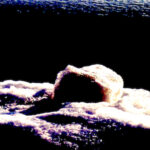Giacomo Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto
Canzone composta nel 1836 presso la Villa Ferrigni (ora rinominata Villa della Ginestra) di Torre del Greco alle pendici del Vesuvio, La ginestra o il fiore del deserto fu pubblicata postuma per la prima volta nell’edizione napoletana dei Canti curata da Antonio Ranieri (1845). Il componimento, che si apre con una citazione dal Vangelo di Giovanni, è considerato il “testamento poetico” di Leopardi, che qui riflette sulla condizione umana. In essa il Leopardi, sviluppando una polemica già altrove affrontata, contro ogni forma di antropocentrismo e soprattutto contro il risorto spiritualismo ottocentesco, riafferma in termini fieri la propria concezione materialistica e pessimistica del mondo. E tuttavia, pur nel suo radicale pessimismo egli elabora un’utopia solidaristica che vorrebbe gli uomini consociati nella lotta contro il comune nemico, la Natura.
Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι µᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς
E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce (Giovanni, III, 19)
Qui su l’arida schiena
del formidabil monte
sterminator Vesevo,
la qual null’altro allegra arbor né fiore,
tuoi cespi solitari intorno spargi, 5
odorata ginestra,
contenta dei deserti. Anco ti vidi
de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade
che cingon la cittade
la qual fu donna de’ mortali un tempo, 10
e del perduto impero
par che col grave e taciturno aspetto
faccian fede e ricordo al passeggero.
Or ti riveggo in questo suol, di tristi
lochi e dal mondo abbandonati amante 15
e d’afflitte fortune ognor compagna.
Questi campi cosparsi
di ceneri infeconde, e ricoperti
dell’impietrata lava,
che sotto i passi al peregrin risona; 20
dove s’annida e si contorce al sole
la serpe, e dove al noto
cavernoso covil torna il coniglio;
fur liete ville e cólti,
e biondeggiar di spiche, e risonaro 25
di muggito d’armenti;
fur giardini e palagi,
agli ozi de’ potenti
gradito ospizio; e fur città famose,
che coi torrenti suoi l’altero monte 30
dall’ignea bocca fulminando oppresse
con gli abitanti insieme. Or tutto intorno
una ruina involve,
ove tu siedi, o fior gentile, e quasi
i danni altrui commiserando, al cielo 35
di dolcissimo odor mandi un profumo,
che il deserto consola. A queste piagge
venga colui che d’esaltar con lode
il nostro stato ha in uso, e vegga quanto
è il gener nostro in cura 40
all’amante natura. E la possanza
qui con giusta misura
anco estimar potrá dell’uman seme,
cui la dura nutrice, ov’ei men teme,
con lieve moto in un momento annulla 45
in parte, e può con moti
poco men lievi ancor subitamente
annichilare in tutto.
Dipinte in queste rive
son dell’umana gente 50
le magnifiche sorti e progressive.
Qui mira e qui ti specchia,
secol superbo e sciocco,
che il calle insino allora
dal risorto pensier segnato innanti 55
abbandonasti, e vòlti addietro i passi,
del ritornar ti vanti,
e procedere il chiami.
Al tuo pargoleggiar gl’ingegni tutti,
di cui lor sorte rea padre ti fece, 60
vanno adulando, ancora
ch’a ludibrio talora
t’abbian fra sé. Non io
con tal vergogna scenderò sotterra;
ma il disprezzo piuttosto che si serra 65
di te nel petto mio,
mostrato avrò quanto si possa aperto;
bench’io sappia che obblio
preme chi troppo all’etá propria increbbe.
Di questo mal, che teco 70
mi fia comune, assai finor mi rido.
Libertà vai sognando, e servo a un tempo
vuoi di novo il pensiero,
sol per cui risorgemmo
della barbarie in parte, e per cui solo 75
si cresce in civiltà, che sola in meglio
guida i pubblici fati.
Così ti spiacque il vero
dell’aspra sorte e del depresso loco
che natura ci die’. Per queste il tergo 80
vigliaccamente rivolgesti al lume
che il fe’ palese; e, fuggitivo, appelli
vil chi lui segue, e solo
magnanimo colui
che sé schernendo o gli altri, astuto o folle, 85
fin sopra gli astri il mortal grado estolle.
Uom di povero stato e membra inferme
che sia dell’alma generoso ed alto,
non chiama sé né stima
ricco d’or né gagliardo, 90
e di splendida vita o di valente
persona infra la gente
non fa risibil mostra;
ma sé di forza e di tesor mendíco
lascia parer senza vergogna, e noma 95
parlando, apertamente, e di sue cose
fa stima al vero uguale.
Magnanimo animale
non credo io già, ma stolto,
quel che nato a perir, nutrito in pene, 100
dice, a goder son fatto,
e di fetido orgoglio
empie le carte, eccelsi fati e nove
felicità, quali il ciel tutto ignora,
non pur quest’orbe, promettendo in terra 105
a popoli che un’onda
di mar commosso, un fiato
d’aura maligna, un sotterraneo crollo
distrugge sí, che avanza
a gran pena di lor la rimembranza. 110
Nobil natura è quella
che a sollevar s’ardisce
gli occhi mortali incontra
al comun fato, e che con franca lingua,
nulla al ver detraendo, 115
confessa il mal che ci fu dato in sorte,
e il basso stato e frale;
quella che grande e forte
mostra sé nel soffrir, né gli odii e l’ire
fraterne, ancor piú gravi 120
d’ogni altro danno, accresce
alle miserie sue, l’uomo incolpando
del suo dolor, ma dà la colpa a quella
che veramente è rea, che de’ mortali
madre è di parto e di voler matrigna. 125
Costei chiama inimica; e incontro a questa
congiunta esser pensando,
siccome è il vero, ed ordinata in pria
l’umana compagnia,
tutti fra sé confederati estima 130
gli uomini, e tutti abbraccia
con vero amor, porgendo
valida e pronta ed aspettando aita
negli alterni perigli e nelle angosce
della guerra comune. Ed alle offese 135
dell’uomo armar la destra, e laccio porre
al vicino ed inciampo,
stolto crede cosí, qual fora in campo
cinto d’oste contraria, in sul più vivo
incalzar degli assalti, 140
gl’inimici obbliando, acerbe gare
imprender con gli amici,
e sparger fuga e fulminar col brando
infra i propri guerrieri.
Così fatti pensieri 145
quando fien, come fur, palesi al volgo;
e quell’orror che primo
contra l’empia natura
strinse i mortali in social catena,
fia ricondotto in parte 150
da verace saper, l’onesto e il retto
conversar cittadino,
e giustizia e pietade altra radice
avranno allor che non superbe fole,
ove fondata probità del volgo 155
così star suole in piede
quale star può quel c’ha in error la sede.
Sovente in queste rive,
che, desolate, a bruno
veste il flutto indurato, e par che ondeggi, 160
seggo la notte; e su la mesta landa,
in purissimo azzurro
veggo dall’alto fiammeggiar le stelle,
cui di lontan fa specchio
il mare, e tutto di scintille in giro 165
per lo vòto seren brillare il mondo.
E poi che gli occhi a quelle luci appunto,
ch’a lor sembrano un punto,
e sono immense, in guisa
che un punto a petto a lor son terra e mare 170
veracemente; a cui
l’uomo non pur, ma questo
globo, ove l’uomo è nulla,
sconosciuto è del tutto; e quando miro
quegli ancor più senz’alcun fin remoti 175
nodi quasi di stelle,
ch’a noi paion qual nebbia, a cui non l’uomo
e non la terra sol, ma tutte in uno,
del numero infinite e della mole,
con l’aureo sole insiem, le nostre stelle 180
o sono ignote, o così paion come
essi alla terra, un punto
di luce nebulosa; al pensier mio
che sembri allora, o prole
dell’uomo? E rimembrando 185
il tuo stato quaggiù, di cui fa segno
il suol ch’io premo; e poi dall’altra parte,
che te signora e fine
credi tu data al Tutto; e quante volte
favoleggiar ti piacque, in questo oscuro 190
granel di sabbia, il qual di terra ha nome,
per tua cagion, dell’universe cose
scender gli autori, e conversar sovente
co’ tuoi piacevolmente, e che i derisi
sogni rinnovellando, ai saggi insulta 195
fin la presente età, che in conoscenza
ed in civil costume
sembra tutte avanzar; qual moto allora,
mortal prole infelice, o qual pensiero
verso te finalmente il cor m’assale? 200
Non so se il riso o la pietá prevale.
Come d’arbor cadendo un picciol pomo,
cui là nel tardo autunno
maturità senz’altra forza atterra,
d’un popol di formiche i dolci alberghi 205
cavati in molle gleba
con gran lavoro, e l’opre,
e le ricchezze che adunate a prova
con lungo affaticar l’assidua gente
avea provvidamente al tempo estivo, 210
schiaccia, diserta e copre
in un punto; così d’alto piombando,
dall’utero tonante
scagliata al ciel profondo,
di ceneri e di pomici e di sassi 215
notte e ruina, infusa
di bollenti ruscelli,
o pel montano fianco
furiosa tra l’erba
di liquefatti massi 220
e di metalli e d’infocata arena
scendendo immensa piena,
le cittadi che il mar là su l’estremo
lido aspergea, confuse
e infranse e ricoperse 225
in pochi istanti: onde su quelle or pasce
la capra, e città nove
sorgon dall’altra banda, a cui sgabello
son le sepolte, e le prostrate mura
l’arduo monte al suo piè quasi calpesta. 230
Non ha natura al seme
dell’uom piú stima o cura
che alla formica: e se più rara in quello
che nell’altra è la strage,
non avvien ciò d’altronde 235
fuor che l’uom sue prosapie ha men feconde.
Ben mille ed ottocento
anni varcàr poi che spariro, oppressi
dall’ignea forza, i popolati seggi,
e il villanello intento 240
ai vigneti, che a stento in questi campi
nutre la morta zolla e incenerita,
ancor leva lo sguardo
sospettoso alla vetta
fatal, che nulla mai fatta più mite 245
ancor siede tremenda, ancor minaccia
a lui strage ed ai figli ed agli averi
lor poverelli. E spesso
il meschino in sul tetto
dell’ostel villereccio, alla vagante 250
aura giacendo tutta notte insonne,
e balzando più volte, esplora il corso
del temuto bollor, che si riversa
dall’inesausto grembo
sull’arenoso dorso, a cui riluce 255
di Capri la marina
e di Napoli il porto e Mergellina.
E se appressar lo vede, o se nel cupo
del domestico pozzo ode mai l’acqua
fervendo gorgogliar, desta i figliuoli, 260
desta la moglie in fretta, e via, con quanto
di lor cose rapir posson, fuggendo,
vede lontan l’usato
suo nido, e il picciol campo,
che gli fu dalla fame unico schermo, 265
preda al flutto rovente,
che crepitando giunge, e inesorato
durabilmente sovra quei si spiega.
Torna al celeste raggio
dopo l’antica obblivion, l’estinta 270
Pompei, come sepolto
scheletro, cui di terra
avarizia o pietà rende all’aperto;
e dal deserto foro
diritto infra le file 275
de’ mozzi colonnati il peregrino
lunge contempla il bipartito giogo
e la cresta fumante,
ch’alla sparsa ruina ancor minaccia.
E nell’orror della secreta notte 280
per li vacui teatri,
per li templi deformi e per le rotte
case, ove i parti il pipistrello asconde,
come sinistra face
che per vòti palagi atra s’aggiri, 285
corre il baglior della funerea lava,
che di lontan per l’ombre
rosseggia e i lochi intorno intorno tinge.
Così, dell’uomo ignara e dell’etadi
ch’ei chiama antiche, e del seguir che fanno 290
dopo gli avi i nepoti,
sta natura ognor verde, anzi procede
per sì lungo cammino
che sembra star. Caggiono i regni intanto,
passan genti e linguaggi: ella nol vede: 295
e l’uom d’eternità s’arroga il vanto.
E tu, lenta ginestra,
che di selve odorate
queste campagne dispogliate adorni,
anche tu presto alla crudel possanza 300
soccomberai del sotterraneo foco,
che ritornando al loco
già noto, stenderà l’avaro lembo
su tue molli foreste. E piegherai
sotto il fascio mortal non renitente 305
il tuo capo innocente:
ma non piegato insino allora indarno
codardamente supplicando innanzi
al futuro oppressor; ma non eretto
con forsennato orgoglio inver le stelle, 310
né sul deserto, dove
e la sede e i natali
non per voler ma per fortuna avesti;
ma più saggia, ma tanto
meno inferma dell’uom, quanto le frali 315
tue stirpi non credesti
o dal fato o da te fatte immortali.
Parafrasi
Qui sulle pendici aride del terribile vulcano sterminatore Vesuvio, che nessun altro arbusto o fiore rallegra, spargi intorno i tuoi cespugli solitari, odorosa ginestra, appagata dai deserti. Ti ho vista anche abbellire con i tuoi steli le campagne solitarie che circondano la città (Roma) che fu un tempo signora di popoli, e sembra che questi luoghi col loro aspetto severo e silenzioso sian testimonianza e ricordo al viandante del perduto impero. Ti rivedo ora su questo suolo, amante di luoghi tristi e abbandonati dal mondo, sempre compagna di sorti sventurate. Questi campi, cosparsi di sterili ceneri e ricoperti di lava pietrificata che risuona sotto i passi del viandante, dove la serpe si annida e si contorce al sole e dove il coniglio torna all’abituale tana sotterranea, furono fiorenti cittadine e campi coltivati, biondeggiarono di spighe e risuonarono del muggito delle mandrie; furono giardini e palazzi gradito rifugio per gli ozi dei potenti; furono sede di città famose, che l’indomabile vulcano con i suoi torrenti di lava eruttando dalla bocca di fuoco distrusse, insieme ai suoi abitanti. Ora tutto intorno la rovina avvolge i luoghi dove tu hai radici, o fiore gentile, e come per commiserare le altrui miserie, diffondi verso il cielo un profumo, che consola questo deserto.
In questi luoghi venga chi è solito esaltare e lodare la condizione umana, e veda quanto la nostra specie stia a cuore all’amorevole natura. E qui potrà anche valutare esattamente l’effettiva potenza del genere umano, che la crudele nutrice (la natura), quando egli meno se l’aspetta, distrugge in parte in un momento con un lieve moto, e può con moti di poco meno lievi annientare del tutto in un istante. Raffigurate su queste pendici sono le “magnifiche sorti e progressive” del genere umano. Guarda qui e qui specchiati, secolo superbo e sciocco, che abbandonasti la via fin qui segnata dal pensiero rinascimentale e che rivolti indietro i passi, del regredire ti vanti, e progredire lo chiami. Al tuo insensato bamboleggiare tutti gli ingegni, di cui una sorte sciagurata ti fece padre, sono intenti ad adularti, benché a volte, intimamente, ti biasimino in cuor loro.
Non io andrò sotto terra con tale vergogna; ma piuttosto il disprezzo nei tuoi confronti, che ho rinchiuso nel cuore, avrò prima mostrato il più apertamente possibile; benché io sappia che l’oblio colpisce chi troppo spiacque al proprio tempo. Di questo male (l’oblio), che avrò in comune con te, io fin da ora ne rido molto. Vai sognando la libertà, e tuttavia vuoi che di nuovo sia servo il pensiero, il solo grazie al quale risorgemmo dalla barbarie in parte, e con il quale soltanto si può crescere in civiltà, che sola guida il destino della società al meglio. Perciò (secol…) ti spiacque la verità sull’amara sorte e sull’infelice condizione che la natura ci ha assegnato. Perciò le spalle, vigliaccamente hai voltato alla luce della ragione, che la rese evidente; e mentre fuggi, chiami vile chi segue quella via, e definisci magnanimo solo chi, beffando se stesso o gli altri, astuto o folle, eleva il genere umano fin sopra le stelle.
Un uomo di misera condizione e di cagionevole salute, che sia d’animo nobile ed elevato, non chiama né stima se stesso ricco di beni o vigoroso, e non si mette ridicolmente in mostra tra la gente vantando una vita lussuosa o un corpo vigoroso, ma senza vergogna si mostra privo di forza fisica e di beni materiali, e definisce e valuta apertamente la sua condizione in modo aderente alla verità. Non penso che sia un animo magnanimo ma sciocco, colui che benché nato per morire e allevato nelle pene, afferma,“sono nato per godere” e che con il suo fetido orgoglio riempie i libri, promettendo in terra eccelsi destini e straordinaria felicità che l’universo ignora, non solo questa terra a popoli che un’onda di maremoto, una pestilenza, un terremoto possono distruggere in modo tale che ne sopravviva a stento il ricordo.
Un uomo veramente nobile è colui che ha il coraggio di sollevare i propri occhi mortali contro il comune destino, e che con parole sincere, senza nulla togliere alla verità, riconosce il male che ci fu dato in sorte e la nostra misera e fragile condizione; (animo nobile) è quello che si mostra grande e forte nella sofferenza, che non aggiunge alle proprie miserie né gli odi né le violenze tra fratelli, che sono ancora più gravi, dando la responsabilità all’uomo del suo dolore, ma dà la colpa a colei (la natura) che è davvero colpevole, che dei mortali è madre perché li genera ma è matrigna per come li tratta. (Animo nobile è quello che) costei chiama nemica, e che pensando che la società umana, com’è vero, sia stata in origine costituita e ordinata contro di lei, ritiene tutti gli uomini confederati tra loro e tutti li abbraccia con sincero amore, offrendo ed aspettando un valido e pronto aiuto negli alterni pericoli e nelle sofferenze della guerra comune. E crede che sia stolto armare la propria mano contro un altro uomo, e tendere un tranello o un danno contro il proprio vicino, così come sarebbe stolto, in un campo di battaglia circondato dai nemici, proprio nel vivo degli assalti, dimenticando i nemici, intraprendere aspri scontri con gli amici e metterli in fuga e seminare morte con la spada tra i propri guerrieri.
Quando pensieri di questo genere saranno evidenti al popolo, come lo sono stati un tempo, e quando quel terrore che per primo unì gli uomini contro la malvagia natura in una catena solidale (la società), quando la convivenza civile onesta e retta sarà recuperata in parte da un autentico sapere, la giustizia e il senso di pietà avranno allora ben altra radice che non le presuntuose illusioni, su cui si fonda la moralità del popolo che si regge in piedi così come può farlo tutto ciò che si regge sull’errore.
Spesso siedo di notte in mezzo a queste terre che, desolate, il flusso pietrificato della lava riveste di colore scuro, e sembra che ancora ondeggi; su questa landa desolata, nel purissimo azzurro del cielo vedo fiammeggiare dall’alto le stelle, alle quali il mare da lontano fa da specchio, e (vedo) tutto il mondo attorno brillare di luci scintillanti nel firmamento sereno. Quando fisso lo sguardo a quelle luci, che ai miei occhi appaiono solo dei punti, e invece sono immense, così che in realtà terra e mare sono un punto rispetto a loro, per le quali (stelle) non solo l’uomo ma la stessa Terra, dove l’uomo è nulla, è completamente sconosciuta; e quando contemplo con meraviglia quegli ammassi di stelle simili a nodi ancor più infinitamente da noi lontani, che ci sembrano come una nebbia, alle quali non l’uomo e non la terra soltanto, ma tutte insieme le nostre stelle, insieme con il luminoso sole, infinite per numero e per mole, o sono ignote o appaiono come loro sembrano a noi, cioè un punto di luce fioca; che cosa sembri allora al mio pensiero, stirpe dell’uomo?
E considerando il tuo stato sulla terra, di cui è testimonianza il suolo vulcanico che io calpesto; e d’altra parte (considerando) che ti reputi assegnata come signora e fine all’universo; e pensando a quante volte ti è piaciuto favoleggiare che i creatori dell’universo siano scesi per causa tua su questo oscuro granello di sabbia, che ha il nome di terra e abbiano spesso conversato piacevolmente con gli uomini; e (considerando) che persino l’età presente che pretende di superare tutte le precedenti in sapere e in civiltà, schernisce i saggi (che non ci credono) e rinnova le false credenze un tempo ridicolizzate; quale sentimento allora, o umanità infelice, quali pensieri verso di te, infine, mi prendono il cuore? Non so se prevalga il riso o la pietà.
Come il piccolo frutto di un albero, che nell’autunno inoltrato la maturazione fa precipitare a terra senza altra forza, schiaccia, annienta e cancella in un attimo i dolci nidi di un popolo di formiche, scavati nella terra molle con gran lavoro, e le gallerie e le provviste di cibo che con lungo affaticarsi le laboriose formiche avevano raccolto a gara con previdenza nella stagione estiva; allo stesso modo, piombando dall’alto, scagliata in alto verso il cielo dalle viscere tuonanti del vulcano un’oscura e rovinosa valanga di ceneri, di pomici e di sassi mescolata a ruscelli incandescenti di lava, o un’immensa piena di massi liquefatti e di metalli fusi e di terra rovente che scende furiosa tra l’erba, lungo le pendici del monte scendendo come un’immensa piena sconvolse e distrusse e ricoprì in pochi istanti le città che il mare bagnava là sulla costa: così ora su quelle città pascolano le capre, e nuove città sorgono dall’altra parte, a cui fanno da sgabello le città sepolte, e l’alto monte quasi calpesta col suo piede le mura crollate.
La natura non ha, per il genere umano, più stima o cura che per le formiche: e se la strage è più rara tra gli uomini che tra le formiche, ciò non accade d’altra parte se non perché l’uomo ha generazioni meno feconde. Sono passati ben mille e ottocento anni da quando scomparvero, sepolte dalla forza della lava infuocata, le popolose città, eppure ancora oggi il contadino al lavoro nei vigneti, che la zolla morta ed incenerita nutre a fatica in questi campi, solleva lo sguardo timoroso alla vetta funesta del vulcano che per nulla divenuta più mite, ancor sovrasta tremenda, ancora minaccia strage per lui, per i suoi figli e per i loro miseri averi. E spesso il poveretto sul tetto della sua rustica casa, restando sveglio insonne tutta la notte all’aria aperta, e sobbalzando più volte di paura, osserva ansioso il procedere della temuta lava, che si riversa inesauribile dalle viscere del vulcano sul pendio sabbioso, al cui bagliore rilucono la marina di Capri e il porto di Napoli e Mergellina. E se la vede avvicinarsi, o se per caso sente l’acqua gorgogliare nel fondo del pozzo di casa, sveglia in fretta i figli e la moglie, e mentre fugge via, con tutto quel che delle loro cose possono raccattare, vede da lontano il suo consueto nido e il piccolo campo, che fu per lui unica difesa alla fame, preda della lava incandescente che sopraggiunge crepitando, e inesorabile si distende per sempre su di essi (la casa e il campo).
Torna ai raggi del sole dopo un oblio di secoli, l’estinta Pompei, come uno scheletro sepolto, riesumata dalla terra alla luce per desiderio di ricchezza o per pietà; e dalla piazza deserta dritto in mezzo alle fila dei colonnati diroccati il pellegrino contempla da lontano la doppia cima del monte (il Vesuvio e il monte Somma), e la cresta fumante, che ancora minaccia le rovine sparse. E nell’orrore della notte che nasconde ogni cosa attraverso i teatri vuoti attraverso i templi diroccati e attraverso le case in rovina, dove il pipistrello nasconde i propri nati, come una sinistra fiaccola che si aggiri lugubre per i vuoti palazzi, corre il bagliore della lava mortale, che da lontano fra le ombre notturne rosseggia e tinge (di rosso) i luoghi tutt’intorno. Così indifferente all’uomo, alle età che egli chiama antiche, e al susseguirsi delle generazioni umane (dagli avi ai nipoti), la natura rimane sempre giovane e vigorosa, e anzi procede per un così lungo cammino da sembrare immobile. Intanto crollano i regni, si estinguono i popoli e le civiltà: ella non se ne avvede, mentre l’uomo si arroga il vanto dell’eternità.
E tu, flessibile ginestra, che adorni di cespugli odorosi queste campagne deserte, anche tu presto soccomberai alla crudele potenza della lava, che ritornando ai luoghi già devastati, stenderà sui tuoi flessibili arbusti il suo avido flutto. E piegherai sotto il peso mortale il tuo capo innocente senza resistere: ma senza averlo piegato fino allora supplicando invano e codardamente di fronte al tuo futuro oppressore; ma senza averlo eretto (il capo) con folle orgoglio verso le stelle, né sul deserto, dove sei cresciuta e hai dimora non per tua scelta ma per caso; ma più saggia, ma tanto meno insensata dell’uomo, poiché non hai mai creduto che la tua specie fosse dal destino o da te stessa resa immortale.
Analisi del testo
La ginestra o il fiore del deserto è un lungo poemetto di 317 versi in cui confluisce una grande varietà di toni e di temi. Esso costituisce una sorta di “testamento spirituale” del poeta, che morì l’anno successivo alla sua stesura.
Il poeta pone come epigrafe un versetto tratto dal Vangelo di Giovanni: “E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce”, dove la luce è quella della fede e della rivelazione. Leopardi invece, con una sorta di ribaltamento, vede nella luce la consapevolezza della tragica condizione umana, mentre le tenebre rappresentano le concezioni spiritualistiche e ottimistiche, la fede cieca nel progresso e nella centralità dell’uomo nell’universo.
Prima strofa (vv. 1-51)
La ginestra e l’unico segno di vita sulle pendici desolate del Vesuvio, dove un tempo sorgevano giardini, palazzi e popolose città, distrutte dall’eruzione del vulcano. L’umile fiore abbellisce questi luoghi deserti, dove coloro che glorificano la potenza dell’uomo dovrebbero venire a constatarne la fragilità e quanto la natura se ne curi.
Alcune immagini caratterizzano il paesaggio: il “formidabil monte” con la sua potenza distruttiva; le “erme contrade” attorno a Roma, immagine di desolazione e abbandono; le “ceneri infeconde” e l’”impietrata lava” che reificano la totale assenza di vita di quei luoghi.
In questo contesto la ginestra è “contenta dei deserti” che abbellisce e “consola” con il suo profumo.
Il poeta invita chi “d’esaltar con lode il nostro stato ha in uso” a verificare in questo luogo un tempo abitato e ridente e ora desertico “quanto/è il gener nostro in cura/all’amante natura”, perché, dice ironicamente, “dipinte in queste rive/son dell’umana gente/le magnifiche sorti e progressive”. Qui è la testimonianza di quanto valga l’uomo e di quanto la natura si curi di lui.
Seconda strofa (vv. 52-86)
L’Ottocento viene definito da Leopardi “secol superbo e sciocco”, perché ha abbandonato il pensiero rinascimentale e illuministico fondato sulla ragione, che aveva liberato in parte l’uomo dalla barbarie. Sicché, codardamente gli intellettuali esaltano la stupidità dell’epoca presente e occultano l’aspra sorte del genere umano. Il poeta non si unisce al coro ottimistico degli intellettuali suoi contemporanei e denuncia l’atteggiamento retrogrado del suo secolo. Questa età esalta in modo arrogante e folle il proprio presunto progresso, mentre di fatto sta regredendo, e recupera una visione della realtà falsa e illusoria. Leopardi esprime il proprio disprezzo per gli intellettuali suoi contemporanei che seguono ingannevoli dottrine di tipo provvidenzialistico e ottimistico. Essi hanno abbandonato la via della ragione e rifiutano di riconoscere la verità della sorte infelice assegnata dalla natura al genere umano.
Terza strofa (vv. 87-157)
Riconoscere la propria fragilità, senza mascherare ridicolmente la propria condizione di miseria non è segno di debolezza. Non è da persona magnanima occultare la condizione umana, illudendo gli uomini di chissà quale felice destino li attenda.
Nobile uomo è invece chi, riconosciuta la natura come la vera, comune nemica e rifiutando di accusare gli altri uomini dei propri mali e di combatterli, si stringe a loro in una solidale guerra contro di lei. Così ha avuto origine la società umana, che si è stretta in social catena per difendersi dai pericoli dell’empia natura.
La vera grandezza d’animo consiste nel riconoscere la dura verità: l’uomo è in completa balia della natura e contro di lei si devono coalizzare gli sforzi di tutti gli esseri umani. Solo unendosi contro il comune nemico, fondandosi su una veritiera analisi della propria condizione, gli uomini potranno dar vita a una convivenza civile più umana e più giusta, capace di rendere meno aspre le loro sofferenze.
Quarta strofa (vv. 158-201)
Spesso di notte il poeta contempla il cielo punteggiato di stelle. Davanti all’immensità del firmamento la terra non è che un minuscolo granello di sabbia e nella vastità dell’universo l’intero sistema solare non è che un punto di luce fioca.
Eppure l’umanità continua a credersi padrona e fine dell’universo. Di fronte a questa assurda pretesa e al riaffiorare di miti antropocentrici del passato, il poeta è combattuto tra il riso (per questo sciocco orgoglio) e il pianto (di commiserazione).
Quinta strofa (vv. 202-236)
Nella quinta strofa il poeta mette a confronto la condizione degli uomini e delle formiche: come un frutto maturo cadendo da un ramo distrugge in un attimo un formicaio costruito con tanta fatica, così l’eruzione del vulcano distrusse in pochi attimi popolose città.
La natura distrugge con la stessa indifferenza e facilità uomini e formiche. Se di queste ultime fa strage con maggior frequenza, è solo perché sono più numerose degli uomini.
Sesta strofa (vv. 237-296)
Mentre la quarta strofa fa leva sul tema della vastità degli spazi cosmici, la sesta mette a confronto il tempo umano con il tempo eterno della natura.
Sono passati diciotto secoli dall’eruzione catastrofica del Vesuvio e l’uomo è tornato a vivere in quei luoghi, ma è sempre sotto l’incubo del vulcano, come il “villanello” che guarda inquieto la vetta del monte ed è sempre all’erta e pronto a fuggire. Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce l’antica Pompei ma il Vesuvio è sempre là, minaccioso, e tra le rovine della città si scorge il lugubre bagliore della lava, portatrice di morte. Le epoche umane passano, cadono i regni e i popoli, mentre la natura dura, uguale a se stessa.
Settima strofa (vv. 297-317)
Intanto la ginestra continua a vivere la sua precaria esistenza sotto la minaccia del vulcano e a diffondere il proprio profumo. La distruzione colpirà anche lei, che non cercherà di resistere ma piegherà il capo sotto il peso della lava. Non l’avrà però piegato prima, implorando inutilmente e vilmente di essere risparmiata.
Non l’avrà sollevato verso le stelle con forsennato orgoglio, tanto più saggia dell’uomo poiché non si illude, come il genere umano, di avere un destino d’immortalità.
L’arido vero e le superbe fole
Leopardi afferma la necessità di affrontare l’arido vero. Questa profonda convinzione si manifesta come disprezzo e riso nei confronti di quanti si illudono, per volontà consolatoria e debolezza o per superbia intellettuale, che l’uomo sia destinato all’immortalità o a “magnifiche sorti e progressive”.
Leopardi polemizza da un lato contro lo spiritualismo cristiano ma anche contro quel pensiero illusoriamente ottimista circa le possibilità di un progresso legato allo sviluppo delle scienze e delle tecniche. La polemica di Leopardi contro il pensiero ottocentesco, che ha recuperato le “superbe fole”, ovvero le credenze e le superstizioni umane, in particolare quelle di natura finalistica e provvidenziale, che interpretano il mondo come concepito in funzione dell’essere umano. Essa si fonda sulla constatazione di un evidente “regresso” della cultura rispetto alle acquisizioni compiute a partire dal Rinascimento e dall’Illuminismo.
La ginestra
Il riconoscimento dell’arido vero non è condizione di felicità, ma il presupposto indispensabile per riconoscere la comune, dura condizione umana, da cui può originare una solidale “social catena”. Gli uomini, deposto il loro stupido orgoglio, come la ginestra dovrebbero affrontare con fermezza la realtà, unendosi nell’affrontare il “deserto” della vita. La ginestra è una metafora dell’uomo che ha raggiunto una profonda consapevolezza filosofica, e della poesia che leva con coraggio la sua voce nonostante la definitiva caduta di ogni illusione.
L’arido vero e la poesia
Leopardi è convinto della necessità di affrontare virilmente l’arido vero, facendone materia di poesia. Egli sul piano formale sostituisce al lessico vago e indefinito degli idilli un “linguaggio antimelodico e aggressivo, che morde ed esacerba la realtà” (Binni).
Copyright © 2019 giorgiobaruzzi. All Rights Reserved.