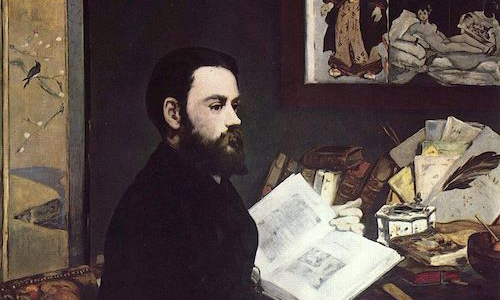Melville, Il capitano Achab
(da Herman Melville, Moby Dick)
XXVIII • ACHAB
Per parecchi giorni dalla partenza del Pequod, non c’è traccia visibile del capitano Achab e sono gli ufficiali di bordo a governare la nave. Eppure, appare evidente che essi eseguono gli ordini repentini e perentori del vero, benché invisibile, comandante. Poi, a un tratto una mattina, salito in coperta all’appello del primo turno di guardia, Ismaele guarda e lo vede…
[…] il capitano Achab era sul cassero.
All’aspetto non mostrava segno riconoscibile di malattia, e neanche pareva in convalescenza. Aveva l’aria di uno staccato dal rogo mentre che il fuoco gli copre e devasta le carni, ma senza consumarle o rubare nemmeno un briciolo della loro durezza fitta e matura. Tutta la sua figura alta e grande pareva fatta di bronzo massiccio e gettata in uno stampo inalterabile, come il Perseo fuso da Cellini. Tra i capelli grigi si faceva strada un segno sottile come una bacchetta, di un biancore livido, e gli scendeva su un lato della faccia e del collo scuri e bruciacchiati, finché spariva nel vestito. Somigliava alla cicatrice perpendicolare prodotta a volte nel tronco alto e dritto di un grande albero, quando il fulmine vi guizza sopra lacerante, e senza svellere un solo rametto spella e scava la corteccia da cima a fondo prima di scaricarsi per terra, lasciandolo vivo e verde ma segnato. Nessuno sapeva con certezza se quel segno era nato con lui, o se era la cicatrice di qualche ferita tremenda. Come per un tacito accordo, durante tutto il viaggio nessuno quasi ne parlò mai, e meno di tutti gli ufficiali. […]
Restai così impressionato da tutta l’aria torva di Achab e da quello sfregio livido che lo rigava, che quasi non notai, dapprima, come quella sua aria losca e insopportabile fosse dovuta in gran parte a quella barbara gamba bianca sulla quale si appoggiava a metà. Avevo già saputo che quest’arto d’avorio glielo avevano costruito in mare dall’osso levigato di una mascella di capodoglio. «Sì, l’hanno disalberato al largo del Giappone,» aveva detto una volta il vecchio indiano del Capo. «Ma ha fatto come il suo bastimento, ha imbarcato un altro albero senza tornare a casa. Ne ha tutto un fascio.»
Mi colpì lo strano modo in cui stava dritto. Ai due lati del cassero, proprio sotto le sartie di mezzana, c’era un buco di trapano sul tavolato, profondo mezzo pollice a occhio e croce.
Con la gamba d’osso piantata in quel buco e un braccio alzato per reggersi a una sartia, il capitano Achab se ne stava impalato guardando fisso al largo, oltre la prua che beccheggiava eternamente. Nella dedizione ferma e temeraria di quello sguardo c’era una forza pura e infinita, una volontà quieta, invincibile. Non diceva una parola e i suoi ufficiali non fiatavano; ma tradivano chiaramente nelle loro espressioni, nei loro minimi gesti la coscienza inquieta, se non penosa, di trovarsi sotto l’occhio corrucciato del padrone. E non solo: quel triste Achab stava davanti a loro con una crocifissione in faccia, con tutta la dignità augusta, imperiosa e indicibile di un grande dolore.
Si ritirò in cabina quasi subito, quella prima volta che apparì all’aria aperta. Ma dopo quella mattina lo vedemmo ogni giorno, o piantato sul suo perno, o seduto su uno sgabello d’avorio che aveva, o mentre passeggiava pesantemente sulla coperta. Man mano che il cielo si faceva meno cupo e anzi cominciava ad addolcirsi, anche lui se ne restava chiuso sempre di meno, come se soltanto lo squallore del mare invernale lo avesse tenuto così segregato da quando la nave aveva lasciato terra. E a poco a poco finì che stava quasi sempre all’aperto; ma sinora, a giudicare da quello che diceva o faceva sul ponte finalmente assolato, vi pareva inutile come un albero di troppo. Ma per il momento il Pequod stava facendo solo una traversata. La vera caccia sarebbe cominciata dopo, e a quasi tutti i preparativi che richiedevano sorveglianza bastava l’occhio degli ufficiali. Sicché, per il momento, c’era poco o nulla attorno che potesse impegnare o distrarre Achab da se stesso, in modo da cacciare almeno per un poco le nuvole che gli si ammucchiavano a strati sulla fronte, come sempre si addensano attorno alle cime più alte.
Ma non passò molto che la tiepida e soave malìa del dolce clima da vacanza a cui eravamo arrivati parve sottrarlo a poco a poco al suo malumore. Come quando aprile e maggio, ballerine dalle guance rosse, tornano salterellando nei tetri boschi invernali, e persino la vecchia quercia più nuda, la più rugosa e spaccata dal fulmine, s’invoglia a mettere fuori almeno qualche germoglio verde per ricevere quelle visitatrici festose, così Achab, alla fine, si convinse a rispondere un poco alle tentazioni scherzose di quell’aria adolescente. E più di una volta si lasciò spuntare in faccia, come un germoglio timido, un’espressione che in qualsiasi altro uomo sarebbe sboccata presto in un sorriso.
XXXVI • IL CASSERO
Una mattina Achab sale in coperta in preda a una visibile agitazione e cammina avanti e indietro per tutto il giorno. Poi, verso sera…
Le ore passavano. Achab s’era chiuso in cabina e subito dopo s’era rimesso a passeggiare sul ponte con la stessa aria esaltata.
La giornata stava per finire. All’improvviso s’inchiodò vicino alla murata, cacciò la gamba d’osso nel buco di trivello, con una mano s’appigliò a una sartia e ordinò a Stubb di mandargli tutti a poppa.
«Capitano?» fece il secondo, strabiliato da quell’ordine che a bordo non si dà quasi mai, tranne che in casi d’emergenza.
«Manda tutti a poppa,» ripeté Achab. «Vedette oh! A basso!»
Quando tutto l’equipaggio fu riunito, e ognuno stava a guardarlo curioso e non senza apprensione, ché la sua faccia non era diversa dall’orizzonte quando si alza un fortunale, Achab dette un’occhiata svelta oltre le murate, e poi saettando gli occhi tra gli uomini si mosse dal suo posto. Come se non avesse un’anima attorno, riprese pesantemente ad andare su e giù per la coperta. E continuava a marciare a testa china e col cappello schiacciato a metà sul naso, incurante dei brontolii di sorpresa dei marinai, finché Stubb sussurrò cautamente a Flask che Achab doveva averli chiamati per assistere a una impresa podistica. Ma non durò a lungo.
Fermandosi con violenza gridò:
«Cosa fate quando vedete una balena, marinai?»
Impulsivamente, una ventina di voci gridarono tutte assieme: «La segnaliamo!»
«Bene!» urlò Achab con un tono di selvaggia approvazione, notando il calore spontaneo in cui li aveva gettati, magneticamente, quella domanda inattesa.
«E che fate poi, marinai?»
«Ammainiamo, e alla caccia!»
«E a che canto vogate, ragazzi?»
«Balena morta o lancia a picco!»
A ogni urlo, il viso del vecchio assumeva sempre più un aspetto strano e selvaggio di approvazione e di gioia. E intanto i marinai cominciavano a guardarsi incuriositi, come sorpresi da quel loro stesso esaltarsi per delle domande che apparivano così oziose. Ma appena Achab ricominciò a parlare tornarono a fissarlo tutti avidi. Si era voltato a metà sul suo perno, e con una mano alzata stringeva stretta, quasi convulsamente, una sartia:
«Tutti voi di vedetta mi avete già sentito dare ordini riguardo a una balena bianca. Guardate qua! Vedete quest’oncia d’oro spagnola?» e alzò al sole una grossa moneta luccicante: «Vale sedici dollari, ragazzi. La vedete? Signor Starbuck, datemi quella mazza.»
Mentre l’ufficiale prendeva il martello, Acbab senza dire niente strofinava pian piano il pezzo d’oro sulle falde della giacca come per farlo più lustro. E intanto cantarellava tra sé a bassa voce, senza parole, producendo un suono soffocato e indistinto così strano, che pareva il ronzare meccanico dell’orgasmo che aveva dentro.
Avuta la mazza da Starbuck l’alzò e camminò verso l’albero maestro, mostrando la moneta d’oro con l’altra mano, e gridando a piena voce: «Chi di voi mi segnala una balena con la testa bianca, la fronte rugosa e la mandibola storta, chi di voi avvista questa balena bianca con tre buchi nella pinna destra della coda, guardate! Chi segnala questa balena avrà quest’oncia d’oro, ragazzi!»
«Urrà! Urrà!» gridarono i marinai, e agitando i cappelli d’incerata festeggiavano i colpi che inchiodavano l’oro sull’albero.
«Una balena bianca, ripeto.» tornò a dire Achab gettando via la mazza, «una balena bianca. Tenete gli occhi aperti, marinai. Attenti all’acqua bianca. Anche se vedete una bolla, segnalate.»
Intanto Tashtego, Daggoo e Queequeg avevano assistito alla scena ancora più sorpresi e interessati degli altri, e a sentire parlare d’una fronte rugosa e d’una mandibola storta avevano trasalito, come se ciascuno per suo conto avesse ricordato qualche fatto particolare.
«Capitano Achab,» disse Tashtego, «questa balena bianca dev’essere quella che certuni chiamano Moby Dick.»
«Moby Dick?» gridò Achab. «Allora conosci la balena bianca, Tash?»
«Capitano, sbatte la coda in modo un po’ curioso prima di tuffarsi?» domandò il Capo Allegro come riflettendo.
«E ha pure uno sfiato curioso,» disse Daggoo, «molto denso anche per uno spermaceti e violentissimo, capitano?»
Allora Queequeg gridò in modo sconnesso: «E ha uno, due, tre, ah, molti ferri nella pelle pure, capitano? Tutti torti storciuti come un… come un…» E balbettava forte cercando la parola, e avvitava una mano in aria come a stappare un fiasco: «Come un… come un…»
«Come un cavatappi!» gridò Achab. «Ma sicuro, Queequeg, ce l’ha dentro tutti storti e piegati, i ramponi; Daggoo, hai ragione, ha una sfiatata come un covone di frumento, e bianca come un mucchio della nostra lana a Nantucket dopo la tosatura; ed è vero, Tashtego, che sbatte la coda come un fiocco strappato dalla burrasca.
Morte e demoni! È Moby Dick che avete visto, ragazzi! Moby Dick, proprio Moby Dick!»
«Capitano Achab,» disse Starbuck, che finora aveva guardato il suo superiore sempre più sbalordito, come Stubb e Flask, ma adesso pareva colpito da un’idea che in qualche modo spiegava tutto: «Capitano Achab, ho sentito parlare di Moby Dick. Ma non è stato Moby Dick a mozzarti la gamba?»
«Chi te l’ha detto?» gridò Achab. Parve esitare: «Ma sì, Starbuck. Ma sì, amici miei, tutti quanti. È stato lui a disalberarmi, lui a regalarmi questo tronco morto su cui ora mi reggo. Ma sì, ma sì!» gridò con un singhiozzo terribile, forte, animalesco come quello di un alce colpito al cuore: «Ma sì, ma sì, è stata quella maledetta balena bianca che mi ha smantellato e mi ha ridotto per sempre un povero buono a niente!» Cominciò a sbattere le braccia e a imprecare paurosamente: «Ma sì, ma sì!» gridava. «E io l’andrò a scovare dietro al Capo di Buona Speranza e al Capo Horn e al Maelstrom e alle fiamme della perdizione prima di perdonargliela. Ed è per questo che vi siete imbarcati, marinai! Per cacciare quella balena bianca su tutti e due i lati del continente e in ogni parte del mondo, per fargli sfiatare sangue nero, per buttarla a pinne in aria. Che ne dite, ragazzi, ci facciamo subito una stretta di mano? Mi sembrate gente di fegato.»
«Sì, sì!» gridarono i ramponieri e i marinai affollandosi attorno al vecchio invasato. «Occhio acuto alla balena bianca, lancia acuta per Moby Dick!»
«Dio vi benedica», e non si capiva se piangeva o urlava, «Dio vi benedica, ragazzi. Dispensiere! Va’ a prendere la misura grande del grog. Ma perché quella faccia lunga, signor Starbuck: non vuoi dargli la caccia, tu, alla balena bianca? Non te la senti di affrontare Moby Dick?»
«Capitano Achab, me la sento di affrontare la sua mascella storta, e anche quelle della morte, se capita per via del mestiere che facciamo. Ma io qui sono venuto a cacciare balene e non a fare vendetta al comandante. Quante botti renderà la tua vendetta se mai l’avrai, capitano Achab? Non ti frutterà molto sul mercato di Nantucket.»
«Uh! Il mercato di Nantucket! Avvicìnati, Starbuck. Con te bisogna andare un po’ più a fondo. Caro mio, se il denaro ha da essere la misura, e poniamo che i contabili hanno stimato il mondo come fosse una banca, fasciandolo di ghinee, una ogni terzo di pollice, allora sì che la mia vendetta mi frutterà un bel premio, da questo punto di vista!»
«Si picchia il petto,» bisbigliò Stubb. «Che significa? Mi pare che suona profondo ma vuoto.»
«Vendetta su un bruto senz’anima!» esclamò Starbuck. «Su un bruto che ti colpì solo per il più cieco istinto! Ma è una pazzia! Capitano Achab, suona blasfemo odiare una creatura incosciente.»
«Stammi a sentire di nuovo. Andiamo ancora un po’ più a fondo. Tutti gli oggetti visibili, amico, sono solo maschere di cartone. Ma in ogni cosa che succede, nell’azione viva, nel fatto preciso, lì, c’è qualche cosa di sconosciuto ma sempre ragionevole che sporge il profilo della faccia da sotto la maschera cieca. Se l’uomo vuole colpire, deve colpire la maschera! Come può evadere il carcerato se non forza il muro? Per me la balena bianca è quel muro. Me l’hanno spinto accanto. Qualche volta penso che lì dietro non c’è niente. Ma è sempre abbastanza. Mi chiama alla prova. Mi opprime. In essa vedo una forza che è un oltraggio, con una malizia inscrutabile che l’innerva. Quella cosa incomprensibile è sopratutto ciò che odio. Forse la balena bianca è il mandatario, e forse è il mandante, ma io gli rovescerò addosso questo mio odio. Non mi parlare di blasfemia, amico; colpirei il sole se mi offendesse. Perché se il sole potesse offendermi, io potrei colpirlo; perché c’è sempre una specie di lealtà nel gioco, e la rivalità presiede su tutta la creazione. Ma io non mi sento soggetto neanche a questa lealtà. Chi è sopra di me? La verità non ha limiti. […]
Da H. Melville, Moby Dick o la Balena, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2011 (Traduzione di Bianca Gioni)
Copyright © 2019 giorgiobaruzzi. All Rights Reserved.