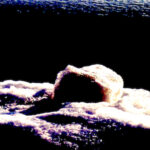Giacomo Leopardi, Dialogo di Tristano e di un Amico
Questo dialogo fu composto nel 1832 come risposta e protesta nei confronti delle critiche aspre e malevoli all’edizione milanese (1827) delle Operette morali, critiche che fra l’altro attribuivano il radicale pessimismo dell’autore alla sua infermità fisica. Tristano/Leopardi di finge di aver mutato parere, di essersi convertito all’ottimismo ottocentesco. Questo accade all’inizio di ogni suo intervento in cui enuncia alcune tesi che mostrerebbero questa sua conversione. Salvo poi, subito dopo, ribaltarle e criticarle con sarcasmo, tanto che a un certo punto l’Amico percepisce la pungente ironia di Tristano.
Amico. Ho letto il vostro libro. Malinconico come al vostro solito.
Tristano. Sì, al mio solito.
Amico. Malinconico, sconsolato, disperato; si vede che questa vita vi sembra una gran brutta cosa.
Tristano. Che cosa dovrei dire? Avevo fisso in capo questa pazzia, che la vita umana fosse infelice.
Amico. Infelice sì forse. Eppure, alla fine…
Tristano. No no, anzi felicissima. Ora ho cambiato opinione. Ma quando scrissi questo libro avevo quell’assurdità per la testa. E ne ero tanto convinto che tutt’altro mi sarei aspettato piuttosto che sentire qualcuno mettere in dubbio le osservazioni che facevo al proposito, sembrandomi che la coscienza di ogni lettore dovesse prontamente confermarle. Pensai che magari si potesse discutere sull’utilità o sul danno di tali osservazioni, non della loro verità. Pensai anzi che i miei lamenti, essendo i mali comuni a tutti gli uomini, sarebbero stati condivisi nel profondo da chiunque li ascoltasse. Invece vidi negare, non qualche passaggio particolare ma il libro nel suo insieme. Sentii affermare che la vita non è infelice e che se a me appariva tale doveva essere perché ero colpito da malattia o da una qualche altra mia disgrazia particolare. Dapprima rimasi attonito, sbalordito, immobile come un sasso e per più giorni pensai di trovarmi in un altro mondo poi, tornato in me stesso, mi risentii un po’. Poi risi. Mi dissi, infatti, che gli uomini sono in generale come i mariti. I mariti, se vogliono vivere tranquilli, è necessario che credano le mogli fedeli, ciascuno la sua. E così fanno, anche quando la metà del mondo sa che la verità è tutt’altra. Per chi vuole o deve vivere in un paese, è opportuno che lo creda uno dei migliori della terra abitabile e perciò lo crede tale. Gli uomini, generalmente, volendo vivere, devono credere che la vita sia bella e pregevole e tale la credono. Si adirano quindi contro chi la pensa diversamente. Infatti, il genere umano crede sempre non alla verità ma a ciò che è o che sembra più opportuno. Il genere umano, che ha creduto e crederà a tante scempiaggini, non crederà mai né di non saper nulla, né di non essere nulla, né di non aver nulla a sperare.
Nessun filosofo che insegnasse una di queste tre cose avrebbe fortuna o seguaci, specie tra il popolo. Infatti, oltre che tutte e tre sono poco adatte a chi vuole vivere, le prime due offendono la superbia degli uomini, la terza e anche le altre due richiedono coraggio e forza d’animo per essere credute. E gli uomini sono codardi, deboli, d’animo ignobile e gretto, pronti sempre a sperar bene, perché sempre dediti a cambiare la propria opinione di ciò che è bene secondo le necessità della loro vita. Prontissimi ad arrendersi, come dice Petrarca, al loro destino, prontissimi e decisi a consolarsi di qualunque sventura. Ad accettare qualunque compenso in cambio di ciò che è loro negato o di ciò che hanno perduto, ad adattarsi a qualsiasi condizione, a qualsiasi sorte, anche la più iniqua e la più barbara. Quando poi siano privati d’ogni cosa desiderabile, sono capaci di vivere di credenze false, in modo così determinato e convinto che potrebbero sembrare le più vere o le più fondate del mondo. Personalmente, così come l’Europa meridionale ride dei mariti innamorati delle mogli infedeli, così io rido del genere umano innamorato della vita. Giudico assai poco virile il voler lasciarsi ingannare e deludere come sciocchi, e oltre ai mali che si soffrono, essere quasi lo zimbello della natura e del destino. Parlo sempre degli inganni non dell’immaginazione, ma dell’intelletto. Se questi miei sentimenti siano causati da malattia non so. So tuttavia che, malato o sano, disprezzo la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogni puerile inganno, e ho il coraggio di sostenere l’assenza di ogni speranza, di guardare con coraggio il deserto della vita, di non mascherare nessun aspetto dell’infelicità umana, e di accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa ma vera. Se essa non è utile ad altro, procura almeno agli uomini forti la nobile soddisfazione di vedere strappata ogni copertura all’occulta e misteriosa crudeltà del destino umano. Io dicevo queste cose fra me, quasi come se quella filosofia dolorosa fosse d’invenzione mia, vedendola tanto rifiutata da tutti, come si respingono le cose nuove o mai sentite. Ma poi, riflettendo, ricordai che essa era tanto nuova quanto Salomone, quanto Omero e i poeti e filosofi più antichi che si conoscano. Tutti costoro descrivono immagini, raccontano storie, esprimono giudizi che denunciano l’estrema infelicità dell’uomo. Alcuni sostengono che l’uomo è il più infelice degli esseri viventi, alcuni dicono che sarebbe meglio non nascere o, se si è nati, morire nella culla. Altri affermano che muore giovane chi è caro agli Dei e altri ancora infinite altre cose di questo genere. Inoltre, mi ricordai che dall’antichità fino a ieri o all’altro ieri, tutti i poeti e tutti i filosofi e gli scrittori grandi e piccoli, in un modo o in un altro, avevano ripetuto o confermato queste teorie.
Sicché di nuovo mi stupii e per molto tempo provai meraviglia, sdegno e riso. Finché, approfondendo l’argomento, riconobbi che l’infelicità dell’uomo era uno degli errori inguaribili dell’intelletto, e che dimostrare la falsità di quest’opinione e la felicità della vita, era una delle grandi scoperte del secolo decimo nono. Allora mi rasserenai, e confesso che avevo torto a credere quello che credevo.
Amico. E avete cambiato opinione?
Tristano. Sicuro. Volete voi che io mi opponga alle verità scoperte dal secolo decimo nono?
Amico. E credete a tutto quello cui crede il secolo?
Tristano. Certamente. Di che vi stupite?
Amico. Credete dunque alla possibilità infinita dell’uomo di perfezionarsi?
Tristano. Senza dubbio.
Amico. Credete quindi che la specie umana stia di giorno in giorno migliorando?
Tristano. Certo. È ben vero che talvolta penso che gli uomini dell’antichità fossero fisicamente forti ciascuno come quattro di noi. E il corpo è l’uomo perché, a parte tutto il resto, la generosità, il coraggio, le passioni, la capacità di agire, la capacità di godere e tutto ciò che fa nobile e viva la vita dipendono dal vigore del corpo, e non ci sono senza quello. Un individuo debole di corpo non è un uomo ma un bambino, anzi peggio. Infatti, il suo destino è di guardare gli altri che vivono e può tutt’al più chiacchierare, ma la vita non è per lui. Perciò nell’antichità la debolezza del corpo fu infamante, anche nei secoli più civili. Tra noi, invece, già da molto tempo l’educazione non si degna di pensare al corpo, considerato cosa troppo bassa e spregevole. Si pensa piuttosto allo spirito e volendo appunto coltivare lo spirito si rovina il corpo, senza accorgersi che rovinando questo, si rovina viceversa anche lo spirito. Ammesso che si possa rimediare a ciò nell’educazione, non lo si potrebbe senza cambiare radicalmente la moderna condizione della società. Non è possibile rimediare senza cambiare gli altri aspetti della vita privata e pubblica, che nell’antichità favorivano di per sé il miglioramento o la conservazione del corpo, mentre oggi concorrono a deteriorarlo. La conseguenza è che, paragonati agli antichi, noi siamo poco più che bambini e che gli antichi in confronto a noi furono veri uomini. Parlo così degli individui paragonati agli individui, come delle masse (per usare questa graziosissima parola moderna) paragonate alle masse.
Inoltre gli antichi furono di gran lunga più virili di noi anche per quanto riguarda la morale e la filosofia. Tuttavia non mi lascio smuovere da tali piccole obiezioni e sono convinto che la specie umana sia in costante progresso.
Amico. Allora credete che il sapere, o come si dice, i lumi, crescano continuamente.
Tristano. Certamente. Anche se vedo che quanto cresce la volontà d’imparare, tanto diminuisce quella di studiare. E c’è da stupirsi che il numero degli studiosi, ma veri studiosi, che si potevano contare centocinquant’anni fa e anche un po’ dopo era di gran lunga maggiore di quello odierno. E non mi si dica poi che i dotti sono pochi perché in genere le conoscenze non sono più riservate ad alcuni individui, ma suddivise fra molti, e che la quantità di questi compensa la rarità di quelli. Le conoscenze non sono come le ricchezze, che si dividono e si concentrano dando la stessa somma. Quando tutti sanno poco si sa poco, perché la scienza va dietro alla scienza, e non si dissemina. L’istruzione superficiale non può essere davvero divisa fra molti, ma semmai comune a molti non dotti. Il resto del sapere non appartiene se non a chi sia dotto, e in gran parte a chi sia molto colto. Fatta eccezione per i casi accidentali, solo chi sia dottissimo, e fornito personalmente di un grande patrimonio di conoscenze, può far crescere e progredire veramente il sapere umano. Ora, eccetto forse in Germania, dove la cultura non è stata ancora estirpata, non vi sembra che l’emergere di uomini molto dotti divenga ogni giorno meno possibile? Faccio queste riflessioni tanto per parlare e per fare un po’ di filosofia, o forse per cavillare, non perché io non sia persuaso di ciò che dite. Anzi, anche se vedessi il mondo tutto pieno d’ignoranti impostori da un lato e d’ignoranti presuntuosi dall’altro, tuttavia crederei, come credo, che il sapere e i lumi crescano di continuo.
Amico. Di conseguenza, credete che questo secolo sia superiore a tutti i passati.
Tristano. Sicuro. Così hanno creduto di sé tutti i secoli, anche i più barbari, e così crede il mio secolo, e io con lui. Se poi mi chiedeste in che cosa esso sia superiore agli altri secoli, se nelle cose materiali o in quelle spirituali, mi rifarei alle cose dette prima.
Amico. Insomma, per dirla in due parole, voi pensate quello che pensano i giornali circa la natura e i destini degli uomini e delle cose (poiché ora non parliamo di letteratura né di politica)?
Tristano. Appunto. Credo e abbraccio la profonda filosofia dei giornali che, uccidendo ogni altra letteratura e ogni altro studio, in particolare quelli difficili e faticosi, sono guida e luce della nostra epoca. Non è forse vero?
Amico. Verissimo. Se quel che dite lo dite sul serio e non per burla, siete diventato dei nostri.
Tristano. Sì certamente, dei vostri.
Amico. Oh, che farete allora del vostro libro? Volete che giunga ai posteri con quelle opinioni così contrarie a quelle che ora avete maturato?
Tristano. Ai posteri? Io rido, perché voi scherzate, e se per caso non scherzaste, riderei ancor di più. Non dico per me, ma per quanto riguarda gli individui o le cose individuali del nostro secolo. Capite bene che non c’è da curarsi dei posteri, che ne sapranno tanto, quanto ne seppero gli antenati. Gl’individui sono spariti dinanzi alle masse, dicono elegantemente i pensatori moderni. Perciò è inutile che l’individuo si dia tanto da fare perché, quale che sia il suo merito, non gli resta più da sperare, né da sveglio né in sogno, neppure nella misera ricompensa della gloria. Lasci fare alle masse. Però vorrei che gli esperti di individui e di masse che oggi illuminano il mondo mi spiegassero che cosa le masse siano senza gli individui, giacché sono composte di individui. Ma a proposito del libro e dei posteri: i libri in particolare, che oggi sono scritti in un tempo minore di quel che serve per leggerli, vedete bene che, poiché costano per quello che valgono, così durano in proporzione a quello che costano. Sono convinto che il prossimo secolo tirerà una bellissima riga sopra l’immensa bibliografia del nostro secolo. Ovvero dirà: ci sono intere biblioteche piene di libri costati venti, trenta anni di fatiche, altri meno ma tutti moltissimo lavoro. Leggiamo prima questi, perché è probabile ricavare da loro un’utilità maggiore. Quando non ci sarà altro leggere, allora si leggeranno i libri improvvisati. Amico mio, questo secolo è un secolo di ragazzi, e i pochissimi uomini che rimangono sono costretti a nascondersi per la vergogna, come quel tipo che camminava dritto in un paese di zoppi. E questi bravi ragazzi vogliono fare quello che negli altri tempi hanno fatto gli uomini, facendolo però da ragazzi, a un tratto, senza alcun impegno che li prepari. Anzi, vogliono che il livello cui è giunta la civiltà e la natura del tempo presente e futuro, li liberino per sempre da ogni necessità di lavoro e impegno di lunga durata, per divenire capaci di fare le cose.
Pochi giorni or sono, un mio amico, pratico di amministrazione e di incombenze, mi diceva che anche la mediocrità è divenuta rarissima. Quasi tutti sono incompetenti e incapaci di svolgere quelle attività o quei compiti cui sono stati preposti, per bisogno, per caso o per scelta. In questo in sembra che stia la differenza tra il nostro e gli altri secoli. In tutti i secoli i grandi uomini sono stati rarissimi, ma mentre nei secoli precedenti è prevalsa la mediocrità, nel nostro secolo prevale la nullità. Oggi che tutti vogliono saper fare tutto, sono talmente forti il frastuono e la confusione che non si presta nessuna attenzione ai pochi grandi. Questi sicuramente ci sono, ma in mezzo all’immensa moltitudine dei concorrenti, non riescono a farsi strada. Così, dato che tutti gli incapaci si credono grandi, l’oscurità e la nullità divengono il destino comune sia degli inetti che dei veri grandi. Tuttavia, viva la statistica! Vivano le scienze economiche, morali e politiche, le enciclopedie portatili, i manuali, e le tante belle creazioni del nostro secolo! E viva sempre il diciottesimo secolo! Forse povero di cose, ma ricchissimo di parole, che come si sa è stato sempre un ottimo segno. Consoliamoci, perché per altri sessantasei anni, questo secolo sarà il solo a spiegare le sue ragioni.
Amico. Mi sembra di cogliere, nelle vostre parole, una certa ironia. Dovreste almeno ricordarvi che questo è un secolo di transizione.
Tristano. Quale conclusione ne possiamo ricavare? Tutti i secoli sono stati e saranno, più o meno, di transizione. La società umana non sta mai ferma, e non ci sarà mai un secolo nel quale essa possa conservarsi com’è. Perciò, questa bellissima parola non è un’attenuante per il nostro secolo, non più di quel che lo sia per tutti gli altri. Resta piuttosto da verificare se la nostra società, seguendo la via che oggi segue, possa portare dal bene al meglio o dal male al peggio. Forse volete dire che quella che viviamo è un’epoca di transizione per eccellenza, con il passaggio rapido verso una nuova civiltà molto diversa dalle precedenti. Se è così, mi viene da ridere di questo passaggio rapido, perché i cambiamenti è meglio che siano lenti. Se accadono in breve tempo, dopo poco si torna indietro, e li si deve rifare a poco a poco. Così è sempre successo. Infatti, la natura non procede a salti e forzando la natura non si ottengono risultati che durino. O meglio, quelle trasformazioni precipitose sono solo apparenti, non reali.
Amico. Vi prego, non fate di questi discorsi con troppe persone, perché vi procurerete molti nemici.
Tristano. Poco importa. Ormai né nemici né amici mi faranno gran male.
Amico. O più probabilmente sarete disprezzato, come uno che poco s’intende della moderna filosofia e che poco si cura del progresso della civiltà e dei lumi.
Tristano. Mi dispiace molto, ma che cosa dovrei fare? Se mi disprezzeranno, cercherò di farmene una ragione.
Amico. Ma alla fine, avete cambiato opinione o no? Che cosa si dovrà fare di questo libro?
Tristano. Bruciarlo è la soluzione migliore. Non volendolo bruciare, conservarlo come un libro di sogni poetici, d’invenzioni e di capricci malinconici, come testimonianza dell’infelicità dell’autore. Infatti, in confidenza, mio caro amico, io credo che voi e tutti gli altri siate felici. Quanto a me, però, con permesso vostro e del secolo, sono infelicissimo e mi credo tale, e neanche tutti i giornali dei due mondi potranno persuadermi del contrario.
Amico. Non so quali siano le ragioni di questa vostra infelicità. D’altra parte, se uno è felice o infelice, non può saperlo se non il diretto interessato.
Tristano. Certo. Inoltre vi dico sinceramente, che io non mi sottometto alla mia infelicità, né piego il capo al destino, né vengo a patti con lui, come fanno gli altri uomini. Oso desiderare la morte, e desiderarla più di ogni cosa, con tanto ardore e con tanta sincerità che così intensamente solo pochissimi credo che l’abbiano desiderata. Non vi parlerei in questo modo se non fossi ben certo che, giunta l’ora, i fatti non smentiranno le mie parole. Infatti, benché io ancora non veda segni certi della fine della mia vita, sento tuttavia dentro di me qualcosa che mi fa presagire con certezza che quel momento non sia lontano. Sono troppo maturo per la morte, mi sembra troppo assurdo e incredibile di dovere, così morto come sono spiritualmente e così esaurite in me tutte le illusioni della vita, vivere ancora quaranta o cinquant’anni, che la natura mi potrebbe riservare. Al solo pensiero rabbrividisco. Come però accade per i mali che sopraffanno la nostra immaginazione, così mi sembra che questo sia un incubo impossibile da verificarsi. Anzi, se qualcuno mi parla di un avvenire lontano come di qualcosa che mi riguardi, non posso trattenermi dal sorridere fra me e me, tanta è la mia sicurezza che la strada che mi resta da percorrere non sia lunga. Questo, posso dire, è il solo pensiero che mi sorregge. Libri e studi, che spesso mi stupisco di avere tanto amato, progetti di grandi imprese e speranze di gloria e d’immortalità sono cose delle quali è persino passato il tempo di sorridere.
Dei progetti e delle speranze di questo secolo non rido: desidero con tutto il cuore che abbiano il maggior successo possibile. Lodo, ammiro e onoro sinceramente le buone intenzioni, ma non invidio i posteri né coloro che vivranno ancora a lungo. In altri momenti ho invidiato gli sciocchi, gli stolti e i presuntuosi. Volentieri mi sarei cambiato con loro. Oggi non invidio più né stolti né saggi, né grandi né piccoli, né deboli né potenti. Invidio i morti, e solo con loro mi cambierei. Ogni mia immaginazione piacevole, ogni mio pensiero dell’avvenire, nelle mie riflessioni in solitudine, riguarda la morte e solo quella. Quando penso alla morte, il ricordo dei sogni della mia giovinezza e il pensiero di essere vissuto invano, non mi turbano più come un tempo. Quando giungerà la morte, morirò così tranquillo e contento come se mai avessi sperato e desiderato nient’altro al mondo. Questo è il solo favore che può riconciliarmi con il destino. Se mi proponessero da un lato la fortuna e la fama di Cesare o di Alessandro pulita da ogni macchia, dall’altro di morire oggi, e dovessi scegliere, io direi morire oggi, e non mi servirebbe tempo per decidere.
Analisi del testo
Il Dialogo di Tristano e di un amico fu composto da Leopardi nel 1832 e pubblicato in posizione finale al posto del Timandro nella seconda edizione delle Operette Morali del 1834, in cui svolge la funzione di “prefazione a posteriori e apologia del libro”. Nella prima parte del dialogo troviamo la protesta e l’indignazione di Leopardi per la riduttiva e ingiusta limitazione della validità filosofica del suo pensiero, attribuito da alcuni alla sua malattia. Segue poi la sarcastica polemica contro i pretesi “lumi” del secolo decimonono.
Tristano (Leopardi) finge di aver mutato parere, di essersi convertito all’ottimismo ottocentesco. Questo accade all’inizio di ogni suo intervento in cui enuncia alcune tesi che mostrerebbero questa sua conversione. Salvo poi, subito dopo, ribaltarle e criticarle con sarcasmo, tanto che a un certo punto l’Amico percepisce la pungente ironia di Tristano.
All’inizio del dialogo Tristano dichiara di aver cambiato la propria opinione pessimistica sulla vita. Inizialmente irritato per le critiche ricevute, dice di aver compreso che gli uomini sono come i mariti, che vogliono credere fedeli le proprie mogli, anche se tutti sanno che non lo sono. In altri termini gli uomini vogliono credere che la vita è bella e non si faranno mai convincere del contrario: non si faranno mai convincere di non saper nulla, di non esser nulla e di non aver nulla da sperare. Gli uomini sono codardi e deboli, ma lasciarsi ingannare è da sciocchi. Tristano rifiuta ogni ingannevole consolazione, guarda con coraggio il deserto della vita, con una filosofia che certo è dolorosa ma vera.
Tristano conferma la convinzione “che la specie umana stia di giorno in giorno migliorando”. Ma subito dopo sostiene che gli antichi erano più forti e generosi di noi, perché davano pari importanza al corpo e allo spirito, mentre la società contemporanea, che dice di privilegiare lo spirito e che disprezza il corpo, finisce per deprimere entrambi. Se il corpo è debole, infatti, anche lo spirito lo diventa.
Tristano conferma l’idea dell’Amico “che il sapere, o come si dice, i lumi, crescano continuamente”. Subito dopo però sostiene che nella società moderna scarseggiano gli uomini di grande cultura e si tende a un appiattimento che mortifica gli individui. Tutti vogliono fare tutto, senza adeguata preparazione e senza fatica. Molti sono così coloro che agiscono con approssimazione, improvvisazione, incompetenza. La cosiddetta diffusione della cultura- sostiene Leopardi – è andata a scapito della possibilità di far emergere le persone veramente grandi e capaci. I grandi uomini sono sempre stati pochi e la norma, in tutti i tempi, è stata la mediocrità. Ma nel secolo decimo nono è divenuta la nullità.
Nella parte conclusiva del Dialogo, Tristano/Leopardi dice di desiderare la morte sopra ogni cosa e che lo preoccupa il pensiero di poter vivere ancora a lungo, anche se questa gli sembra un’eventualità quasi impossibile. Il ricordo delle illusioni e dei sogni della giovinezza non lo rattrista più come un tempo. Lungi ormai da pretese di fama e di gloria, l’unica sorte che invidia è quella dei morti.
Il nome del protagonista, Tristano, il nome del protagonista rinvia all’etimologia latina dell’aggettivo tristis, “triste”, ed evoca sia la tragica vicenda dell’eroe di un romanzo cavalleresco medioevale sia il tono ironico del romanzo di Laurence Sterne La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo.
Testo originale: Dialogo di Tristano e di un Amico
Amico. Ho letto il vostro libro. Malinconico al vostro solito.
Tristano. Sì, al mio solito.
Amico. Malinconico, sconsolato, disperato; si vede che questa vita vi pare una gran brutta cosa.
Tristano. Che v’ho a dire? io aveva fitta in capo questa pazzia, che la vita umana fosse infelice.
Amico. Infelice sì forse. Ma pure alla fine.
Tristano. No no, anzi felicissima. Ora ho cambiata opinione. Ma quando scrissi cotesto libro, io aveva quella pazzia in capo, come vi dico. E n’era tanto persuaso, che tutt’altro mi sarei aspettato, fuorché sentirmi volgere in dubbio le osservazioni ch’io faceva in quel proposito, parendomi che la coscienza d’ogni lettore dovesse rendere prontissima testimonianza a ciascuna di esse. Solo immaginai che nascesse disputa dell’utilità o del danno di tali osservazioni, ma non mai della verità: anzi mi credetti che le mie voci lamentevoli, per essere i mali comuni, sarebbero ripetute in cuore da ognuno che le ascoltasse. E sentendo poi negarmi, non qualche proposizione particolare, ma il tutto, e dire che la vita non è infelice, e che se a me pareva tale, doveva essere effetto d’infermità, o d’altra miseria mia particolare, da prima rimasi attonito, sbalordito, immobile come un sasso, e per più giorni credetti di trovarmi in un altro mondo; poi, tornato in me stesso, mi sdegnai un poco; poi risi, e dissi: gli uomini sono in generale come i mariti. I mariti, se vogliono viver tranquilli, è necessario che credano le mogli fedeli, ciascuno la sua; e così fanno; anche quando la metà del mondo sa che il vero è tutt’altro. Chi vuole o dee vivere in un paese, conviene che lo creda uno dei migliori della terra abitabile; e lo crede tale. Gli uomini universalmente, volendo vivere, conviene che credano la vita bella e pregevole; e tale la credono; e si adirano contro chi pensa altrimenti. Perché in sostanza il genere umano crede sempre, non il vero, ma quello che è, o pare che sia, più a proposito suo. Il genere umano, che ha creduto e crederà tante scempiataggini, non crederà mai né di non saper nulla, né di non essere nulla, né di non aver nulla a sperare.
Nessun filosofo che insegnasse l’una di queste tre cose, avrebbe fortuna né farebbe setta, specialmente nel popolo: perché, oltre che tutte tre sono poco a proposito di chi vuol vivere, le due prime offendono la superbia degli uomini, la terza, anzi ancora le altre due, vogliono coraggio e fortezza d’animo a essere credute. E gli uomini sono codardi, deboli, d’animo ignobile e angusto; docili sempre a sperar bene, perché sempre dediti a variare le opinioni del bene secondo che la necessità governa la loro vita; prontissimi a render l’arme, come dice il Petrarca,(1) alla loro fortuna, prontissimi e risolutissimi a consolarsi di qualunque sventura, ad accettare qualunque compenso in cambio di ciò che loro è negato o di ciò che hanno perduto, ad accomodarsi con qualunque condizione a qualunque sorte più iniqua e più barbara, e quando sieno privati d’ogni cosa desiderabile, vivere di credenze false, così gagliarde e ferme, come se fossero le più vere o le più fondate del mondo. Io per me, come l’Europa meridionale ride dei mariti innamorati delle mogli infedeli, così rido del genere umano innamorato della vita; e giudico assai poco virile il voler lasciarsi ingannare e deludere come sciocchi, ed oltre ai mali che si soffrono, essere quasi lo scherno della natura e del destino. Parlo sempre degl’inganni non dell’immaginazione, ma dell’intelletto. Se questi miei sentimenti nascano da malattia, non so: so che, malato o sano, calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogn’inganno puerile, ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita, non dissimularmi nessuna parte dell’infelicità umana, ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa, ma vera. La quale se non è utile ad altro, procura agli uomini forti la fiera compiacenza di vedere strappato ogni manto alla coperta e misteriosa crudeltà del destino umano. Io diceva queste cose fra me, quasi come se quella filosofia dolorosa fosse d’invenzione mia; vedendola così rifiutata da tutti, come si rifiutano le cose nuove e non più sentite. Ma poi, ripensando, mi ricordai ch’ella era tanto nuova, quanto Salomone e quanto Omero, e i poeti e i filosofi più antichi che si conoscano; i quali tutti sono pieni pienissimi di figure, di favole, di sentenze significanti l’estrema infelicità umana; e chi di loro dice che l’uomo è il più miserabile degli animali; chi dice che il meglio è non nascere, e per chi è nato, morire in cuna; altri, che uno che sia caro agli Dei, muore in giovanezza, ed altri altre cose infinite su questo andare.(2) E anche mi ricordai che da quei tempi insino a ieri o all’altr’ieri, tutti i poeti e tutti i filosofi e gli scrittori grandi e piccoli, in un modo o in un altro, avevano ripetute o confermate le stesse dottrine.
Sicché tornai di nuovo a maravigliarmi: e così tra la maraviglia e lo sdegno e il riso passai molto tempo: finché studiando più profondamente questa materia, conobbi che l’infelicità dell’uomo era uno degli errori inveterati dell’intelletto, e che la falsità di questa opinione, e la felicità della vita, era una delle grandi scoperte del secolo decimonono. Allora m’acquetai, e confesso ch’io aveva il torto a credere quello ch’io credeva.
Amico. E avete cambiata opinione?
Tristano. Sicuro. Volete voi ch’io contrasti alle verità scoperte dal secolo decimonono?
Amico. E credete voi tutto quello che crede il secolo?
Tristano. Certamente. Oh che maraviglia?
Amico. Credete dunque alla perfettibilità indefinita dell’uomo?
Tristano. Senza dubbio.
Amico. Credete che in fatti la specie umana vada ogni giorno migliorando?
Tristano. Sì certo. È ben vero che alcune volte penso che gli antichi valevano, delle forze del corpo, ciascuno per quattro di noi. E il corpo è l’uomo; perché (lasciando tutto il resto) la magnanimità, il coraggio, le passioni, la potenza di fare, la potenza di godere, tutto ciò che fa nobile e viva la vita, dipende dal vigore del corpo, e senza quello non ha luogo. Uno che sia debole di corpo, non è uomo, ma bambino; anzi peggio; perché la sua sorte è di stare a vedere gli altri che vivono, ed esso al più chiacchierare, ma la vita non è per lui. E però anticamente la debolezza del corpo fu ignominiosa, anche nei secoli più civili. Ma tra noi già da lunghissimo tempo l’educazione non si degna di pensare al corpo, cosa troppo bassa e abbietta: pensa allo spirito; e appunto volendo coltivare lo spirito, rovina il corpo; senza avvedersi che rovinando questo, rovina a vicenda anche lo spirito. E dato che si potesse rimediare in ciò all’educazione, non si potrebbe mai senza mutare radicalmente lo stato moderno della società, trovare rimedio che valesse in ordine alle altre parti della vita privata e pubblica, che tutte, di proprietà loro, cospirarono anticamente a perfezionare o a conservare il corpo, e oggi cospirano a depravarlo. L’effetto è che a paragone degli antichi noi siamo poco più che bambini, e che gli antichi a confronto nostro si può dire più che mai che furono uomini. Parlo così degl’individui paragonati agl’individui, come delle masse (per usare questa leggiadrissima parola moderna) paragonate alle masse.
Ed aggiungo che gli antichi furono incomparabilmente più virili di noi anche ne’ sistemi di morale e di metafisica. A ogni modo io non mi lascio muovere da tali piccole obbiezioni, credo costantemente che la specie umana vada sempre acquistando.
Amico. Credete ancora, già s’intende, che il sapere, o, come si dice, i lumi, crescano continuamente.
Tristano. Certissimo. Sebbene vedo che quanto cresce la volontà d’imparare, tanto scema quella di studiare. Ed è cosa che fa maraviglia a contare il numero dei dotti, ma veri dotti, che vivevano contemporaneamente cencinquant’anni addietro, e anche più tardi, e vedere quanto fosse smisuratamente maggiore di quello dell’età presente. Né mi dicano che i dotti sono pochi perché in generale le cognizioni non sono più accumulate in alcuni individui, ma divise fra molti; e che la copia di questi compensa la rarità di quelli. Le cognizioni non sono come le ricchezze, che si dividono e si adunano, e sempre fanno la stessa somma. Dove tutti sanno poco, e’ si sa poco; perché la scienza va dietro alla scienza, e non si sparpaglia. L’istruzione superficiale può essere, non propriamente divisa fra molti, ma comune a molti non dotti. Il resto del sapere non appartiene se non a chi sia dotto, e gran parte di quello a chi sia dottissimo. E, levati i casi fortuiti, solo chi sia dottissimo, e fornito esso individualmente di un immenso capitale di cognizioni, è atto ad accrescere solidamente e condurre innanzi il sapere umano. Ora, eccetto forse in Germania, donde la dottrina non è stata ancora potuta snidare, non vi par egli che il veder sorgere di questi uomini dottissimi divenga ogni giorno meno possibile? Io fo queste riflessioni così per discorrere, e per filosofare un poco, o forse sofisticare; non ch’io non sia persuaso di ciò che voi dite. Anzi quando anche vedessi il mondo tutto pieno d’ignoranti impostori da un lato, e d’ignoranti presuntuosi dall’altro, nondimeno crederei, come credo, che il sapere e i lumi crescano di continuo.
Amico. In conseguenza, credete che questo secolo sia superiore a tutti i passati.
Tristano. Sicuro. Così hanno creduto di se tutti i secoli, anche i più barbari; e così crede il mio secolo, ed io con lui. Se poi mi dimandaste in che sia egli superiore agli altri secoli, se in ciò che appartiene al corpo o in ciò che appartiene allo spirito, mi rimetterei alle cose dette dianzi.
Amico. In somma, per ridurre il tutto in due parole, pensate voi circa la natura e i destini degli uomini e delle cose (poiché ora non parliamo di letteratura né di politica) quello che ne pensano i giornali?
Tristano. Appunto. Credo ed abbraccio la profonda filosofia de’ giornali, i quali uccidendo ogni altra letteratura e ogni altro studio, massimamente grave e spiacevole, sono maestri e luce dell’età presente. Non è vero?
Amico. Verissimo. Se cotesto che dite, è detto da vero e non da burla, voi siete diventato de’ nostri.
Tristano. Sì certamente, de’ vostri.
Amico. Oh dunque, che farete del vostro libro? Volete che vada ai posteri con quei sentimenti così contrari alle opinioni che ora avete?
Tristano. Ai posteri? Io rido, perché voi scherzate; e se fosse possibile che non ischerzaste, più riderei. Non dirò a riguardo mio, ma a riguardo d’individui o di cose individuali del secolo decimonono, intendete bene che non v’è timore di posteri, i quali ne sapranno tanto, quanto ne seppero gli antenati. Gl’individui sono spariti dinanzi alle masse, dicono elegantemente i pensatori moderni. Il che vuol dire ch’è inutile che l’individuo si prenda nessun incomodo, poiché, per qualunque suo merito, né anche quel misero premio della gloria gli resta più da sperare né in vigilia né in sogno. Lasci fare alle masse; le quali che cosa sieno per fare senza individui, essendo composte d’individui, desidero e spero che me lo spieghino gl’intendenti d’individui e di masse, che oggi illuminano il mondo. Ma per tornare al proposito del libro e de’ posteri, i libri specialmente, che ora per lo più si scrivono in minor tempo che non ne bisogna a leggerli, vedete bene che, siccome costano quel che vagliono, così durano a proporzione di quel che costano. Io per me credo che il secolo venturo farà un bellissimo frego sopra l’immensa bibliografia del secolo decimonono; ovvero dirà: io ho biblioteche intere di libri che sono costati quali venti, quali trenta anni di fatiche, e quali meno, ma tutti grandissimo lavoro. Leggiamo questi prima, perché la verisimiglianza è che da loro si cavi maggior costrutto; e quando di questa sorta non avrò più che leggere, allora metterò mano ai libri improvvisati. Amico mio, questo secolo è un secolo di ragazzi, e i pochissimi uomini che rimangono, si debbono andare a nascondere per vergogna, come quello che camminava diritto in paese di zoppi. E questi buoni ragazzi vogliono fare in ogni cosa quello che negli altri tempi hanno fatto gli uomini, e farlo appunto da ragazzi, così a un tratto, senza altre fatiche preparatorie. Anzi vogliono che il grado al quale è pervenuta la civiltà, e che l’indole del tempo presente e futuro, assolvano essi e loro successori in perpetuo da ogni necessità di sudori e fatiche lunghe per divenire atti alle cose.
Mi diceva, pochi giorni sono, un mio amico, uomo di maneggi e di faccende, che anche la mediocrità è divenuta rarissima: quasi tutti sono inetti, quasi tutti insufficienti a quegli uffici o a quegli esercizi a cui necessità o fortuna o elezione gli ha destinati. In ciò mi pare che consista in parte la differenza ch’è da questo agli altri secoli. In tutti gli altri, come in questo, il grande è stato rarissimo; ma negli altri la mediocrità ha tenuto il campo, in questo la nullità. Onde è tale il romore e la confusione, volendo tutti esser tutto, che non si fa nessuna attenzione ai pochi grandi che pure credo che vi sieno; ai quali, nell’immensa moltitudine de’ concorrenti, non è più possibile di aprirsi una via. E così, mentre tutti gl’infimi si credono illustri, l’oscurità e la nullità dell’esito diviene il fato comune e degl’infimi e de’ sommi. Ma viva la statistica! vivano le scienze economiche, morali e politiche, le enciclopedie portatili, i manuali, e le tante belle creazioni del nostro secolo! e viva sempre il secolo decimonono! forse povero di cose, ma ricchissimo e larghissimo di parole: che sempre fu segno ottimo, come sapete. E consoliamoci, che per altri sessantasei anni, questo secolo sarà il solo che parli, e dica le sue ragioni.
Amico. Voi parlate, a quanto pare, un poco ironico. Ma dovreste almeno all’ultimo ricordarvi che questo è un secolo di transizione.
Tristano. Oh che conchiudete voi da cotesto? Tutti i secoli, più o meno, sono stati e saranno di transizione, perché la società umana non istà mai ferma, né mai verrà secolo nel quale ella abbia stato che sia per durare. Sicché cotesta bellissima parola o non iscusa punto il secolo decimonono, o tale scusa gli è comune con tutti i secoli. Resta a cercare, andando la società per la via che oggi si tiene, a che si debba riuscire, cioè se la transizione che ora si fa, sia dal bene al meglio o dal male al peggio. Forse volete dirmi che la presente è transizione per eccellenza, cioè un passaggio rapido da uno stato della civiltà ad un altro diversissimo dal precedente. In tal caso chiedo licenza di ridere di cotesto passaggio rapido, e rispondo che tutte le transizioni conviene che sieno fatte adagio; perché se si fanno a un tratto, di là a brevissimo tempo si torna indietro, per poi rifarle a grado a grado. Così è accaduto sempre. La ragione è, che la natura non va a salti, e che forzando la natura, non si fanno effetti che durino. Ovvero, per dir meglio, quelle tali transizioni precipitose sono transizioni apparenti, ma non reali.
Amico. Vi prego, non fate di cotesti discorsi con troppe persone, perché vi acquisterete molti nemici.
Tristano. Poco importa. Oramai né nimici né amici mi faranno gran male.
Amico. O più probabilmente sarete disprezzato, come poco intendente della filosofia moderna, e poco curante del progresso della civiltà e dei lumi.
Tristano. Mi dispiace molto, ma che s’ha a fare? se mi disprezzeranno, cercherò di consolarmene.
Amico. Ma in fine avete voi mutato opinioni o no? e che s’ha egli a fare di questo libro?
Tristano. Bruciarlo è il meglio. Non lo volendo bruciare, serbarlo come un libro di sogni poetici, d’invenzioni e di capricci malinconici, ovvero come un’espressione dell’infelicità dell’autore: perché in confidenza, mio caro amico, io credo felice voi e felici tutti gli altri; ma io quanto a me, con licenza vostra e del secolo, sono infelicissimo; e tale mi credo; e tutti i giornali de’ due mondi non mi persuaderanno il contrario.
Amico. Io non conosco le cagioni di cotesta infelicità che dite. Ma se uno sia felice o infelice individualmente, nessuno è giudice se non la persona stessa, e il giudizio di questa non può fallare.
Tristano. Verissimo. E di più vi dico francamente, ch’io non mi sottometto alla mia infelicità, né piego il capo al destino, o vengo seco a patti, come fanno gli altri uomini; e ardisco desiderare la morte, e desiderarla sopra ogni cosa, con tanto ardore e con tanta sincerità, con quanta credo fermamente che non sia desiderata al mondo se non da pochissimi. Né vi parlerei così se non fossi ben certo che, giunta l’ora, il fatto non ismentirà le mie parole; perché quantunque io non vegga ancora alcun esito alla mia vita, pure ho un sentimento dentro, che quasi mi fa sicuro che l’ora ch’io dico non sia lontana. Troppo sono maturo alla morte, troppo mi pare assurdo e incredibile di dovere, così morto come sono spiritualmente, così conchiusa in me da ogni parte la favola della vita, durare ancora quaranta o cinquant’anni, quanti mi sono minacciati dalla natura. Al solo pensiero di questa cosa io rabbrividisco. Ma come ci avviene di tutti quei mali che vincono, per così dire, la forza immaginativa, così questo mi pare un sogno e un’illusione, impossibile a verificarsi. Anzi se qualcuno mi parla di un avvenire lontano come di cosa che mi appartenga, non posso tenermi dal sorridere fra me stesso: tanta confidenza ho che la via che mi resta a compiere non sia lunga. E questo, posso dire, è il solo pensiero che mi sostiene. Libri e studi, che spesso mi maraviglio d’aver tanto amato, disegni di cose grandi, e speranze di gloria e d’immortalità, sono cose delle quali è anche passato il tempo di ridere.
Dei disegni e delle speranze di questo secolo non rido: desidero loro con tutta l’anima ogni miglior successo possibile, e lodo, ammiro ed onoro altamente e sincerissimamente il buon volere: ma non invidio però i posteri né quelli che hanno ancora a vivere lungamente. In altri tempi ho invidiato gli sciocchi e gli stolti, e quelli che hanno un gran concetto di se medesimi; e volentieri mi sarei cambiato con qualcuno di loro. Oggi non invidio più né stolti né savi, né grandi né piccoli, né deboli né potenti. Invidio i morti, e solamente con loro mi cambierei. Ogni immaginazione piacevole, ogni pensiero dell’avvenire, ch’io fo, come accade, nella mia solitudine, e con cui vo passando il tempo, consiste nella morte, e di là non sa uscire. Né in questo desiderio la ricordanza dei sogni della prima età, e il pensiero d’esser vissuto invano, mi turbano più, come solevano. Se ottengo la morte morrò così tranquillo e così contento, come se mai null’altro avessi sperato né desiderato al mondo. Questo è il solo benefizio che può riconciliarmi al destino. Se mi fosse proposta da un lato la fortuna e la fama di Cesare o di Alessandro netta da ogni macchia, dall’altro di morir oggi, e che dovessi scegliere, io direi, morir oggi, e non vorrei tempo a risolvermi.
Copyright © 2019 giorgiobaruzzi. All Rights Reserved.